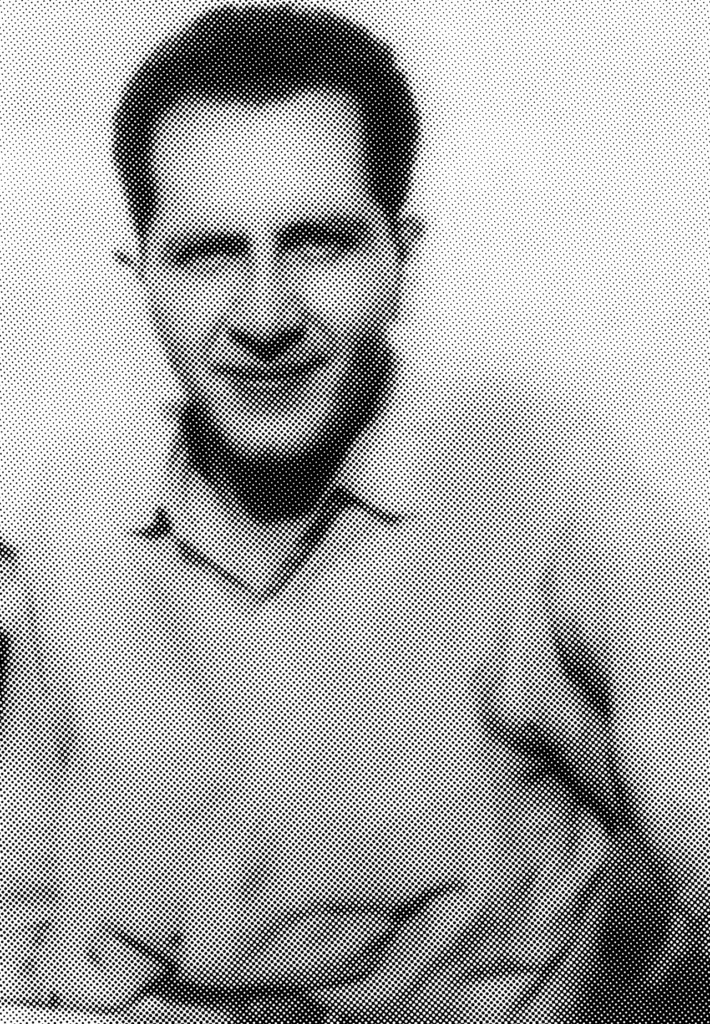La rubrica, a cura di Luigi Fasciana, esordisce con un saggio di Umberto Fiori, che ringraziamo. “Divieto d’accesso. Appunti su Citizen Kane di Orson Welles” è stato scritto per “Sguardi a perdita d’occhio. I poeti leggono il cinema”, ciclo di incontri tenutosi a Bergamo nella primavera del 2010, ed è stato pubblicato in “A+L” n.15 (2010).
di Umberto Fiori
Ho visto Quarto potere per la prima volta quando avevo quindici anni. Ricordo bene il senso di oppressione che mi davano le scene iniziali, quelle in cui Xanadu affiora nel buio, tra i vapori: il cartello NO TRESPASSING, l’interminabile rete metallica, i torrioni e le bifore, le scimmiette, le gondole, le ultime parole del morente (“Rosabella…”). Quel lugubre bianco e nero era lo stesso di certi film “per ragazzi” che alle elementari – senza che nessuno lo sospettasse – mi avevano terrorizzato (Il giardino segreto, 1949, e un altro di cui non ricordo il titolo, solo la scena in cui un invasato uomo-volpe saltella lungo una strada di campagna).
Il risvolto “notturno” del film di Welles, nelle scene successive, veniva provvisoriamente rimosso dai flash-back sulla carriera di Kane. Anche questa vicenda “diurna”, comunque, aveva per un ragazzo italiano degli anni ‘60 (o solo per me, chissà) un sapore torbido, esotico, cupamente irreale. Più che in un altro tempo, il racconto sembrava svolgersi in una dimensione parallela. L’epoca che scene e costumi evocavano non assomigliava in nulla a quelle dei libri di storia: era il vaghissimo Passato dove si aggirano Pollicino, Rosaspina (Rosabella!), Raperonzolo. L’America che correva sullo schermo non era un paese vero. Non poteva esserlo. In quale paese un eminente uomo pubblico avrebbe potuto pronunciare quei discorsi da sempliciotto, sparare profezie da bar, buttar giù in un minuto “dichiarazioni programmatiche” goffamente demagogiche, da diffondere in milioni di copie? Quando e come sarebbero state possibili le fanfaronate di Kane, le sue smorfie, le sue interviste ammiccanti? In quale paese un miliardario avrebbe potuto candidarsi alle elezioni sostenendo di rappresentare gli interessi dei poveri? E poi le battute sui sondaggi, e i coriandoli, le ballerine… Erano queste le “americanate” di cui parlava mia nonna? A quel carnevale di bimbi ingenui e spacconi l’idea italiana di politica, in quegli anni (1964), sembrava ancora irrimediabilmente estranea.
*
Ho rivisto Quarto potere più volte, in diversi periodi della mia vita, e – come capita coi classici – ogni volta ho scoperto qualcosa che mi era sfuggito. Ad esempio, la canzoncina che le chorus girls e il maturo comico in giacca a strisce e straw-hat dedicano a Kane durante la festa al giornale. A quindici anni il mio inglese era assai precario, e i sottotitoli correvano troppo. Più tardi ho avuto modo di riascoltarla con calma:
There is a man – a certain man
And for the poor you may be sure
That he’ll do all he can!
Who is this one?
This fav’rite son?
(…)
It’s Charlie Kane! (1)
Charlie Kane è a tutti gli effetti un inno, ma un inno in stile vaudeville. Che un uomo del peso economico e politico del protagonista, un personaggio pubblico di primo piano, ascolti senza imbarazzi una simile sviolinata, è abbastanza sconcertante (o almeno, lo era negli anni ’60); ma ancor più sconcertante è scoprire quali sono le virtù che il poeta celebra. Al nostro eroe “piace fumare”, “gli piacciono le barzellette” (“Ah! Ah! Ah! Ah!”, sottolinea il coro delle ragazze); nonostante sia ricco e famoso, è rimasto un uomo semplice, che si fa dare del tu; dichiara che “le belle donne sono lì per essere baciate”, e non se ne lascia scappare una; è lui che offre da bere e da mangiare, perché pensa che i soldi siano fatti per essere spesi. Eccetera. A un certo punto, Kane stesso si unisce al balletto e canta in coro le proprie lodi. Potrebbe mai esserci, qui in Italia, un tipo simile?
*
Un altro elemento su cui da ragazzo avevo sorvolato sono i versi che introducono il cinegiornale rievocativo che dà avvio alla storia: In Xanadu did Kubla Khan/ A stately pleasure-dome decree. A quindici anni non sapevo di chi fossero, e non mi pareva poi così importante. Se in nessun luogo del film lo si precisa, è probabilmente perché il loro autore, Samuel T. Coleridge, è troppo noto al pubblico anglo-americano, e la poesia – Kubla Khan – è una delle sue più celebri. Di lì Kane aveva tratto il nome del favoloso palazzo che si era fatto costruire in Florida: Xanadu (in versione italiana – ahimé – Kandalù).
In Xanadu did Kubla Khan
A stately pleasure-dome decree:
Where Alph, the sacred river, ran
Through caverns measureless to man,
Down to a sunless sea. (2)
Chi conosce il testo di Coleridge, sa che Xanadu non è – come i due versi riportati nel film potrebbero far pensare – soltanto un luogo di delizie. I suoi paesaggi ameni e solatii nascondono caverne smisurate, sotterranei di ghiaccio; vi si odono lamenti di donne in amore coi dèmoni, voci ancestrali che annunciano guerra; un fiume scorre nel sottosuolo, per sfociare in “un mare senza sole”, in un “oceano senza vita”. Il breve rimando a Kubla Khan è lì per alludere – in modo obliquo, cifrato – agli angoli più bui dell’anima di Kane, alle caves of ice che si celano sotto il vitalismo e la giovialità del tycoon.
*
Il titolo dell’edizione italiana di Citizen Kane, Quarto potere, presenta il film come una denuncia del peso abnorme che l’informazione può assumere in una democrazia, e dei rischi che una sua concentrazione in poche mani comporta. In effetti, il lavoro di Welles si presta anche a una lettura in questa chiave; ma ciò che fa del “cittadino” Kane un personaggio – e non il cliché del capitalista pancia-cilindro-e-sigaro – è la complessità degli intrecci tra dimensione pubblica e intime tensioni, trionfi e disfatte, pragmatismo e abissi inconsci. Più che una patologia del potere, Welles ci mostra il potere come patologia. La vocazione di Kane, fin da giovane, è quella di manipolare l’opinione pubblica; manipolarla non in base a una certa ideologia (di lui, Leland dice che “E’ morto senza credere a niente”), ma per l’oscuro, tormentoso bisogno di sottometterla. Kane non manca occasione per vantarsi di controllare ciò che pensa la gente; nessuno più di lui, d’altra parte, teme l’altrui giudizio. Quando la sua relazione extraconiugale con Susan Alexander viene scoperta, mettendo fine alla sua carriera politica, i giornali titolano: Mr. Kane sorpreso nel nido d’amore con una “cantante”. Il suo matrimonio con Susan, i suoi folli sforzi per lanciarla nel mondo dell’opera, sono il disperato tentativo di cancellare quelle virgolette. Quando lei, distrutta dai fallimenti, dalla noia e dal disamore, lo sta lasciando, e lui è quasi riuscito a convincerla a restare, ecco che involontariamente si tradisce: “Non andartene, Susan… – piagnucola – Non puoi farmi questo…” “Ah! Ecco! – sbotta lei – Ti brucia solo l’affronto che ti faccio! Io non conto affatto. Quello che provo non importa…”.
*
Eppure, Kane non è un tipo glaciale, refrattario all’amore. L’amore, anzi, è ciò a cui aspira più di ogni altra cosa. L’amore degli altri: questa è la sua ossessione. “Il tuo solo scopo – gli rinfaccia Leland nella sua requisitoria “da ubriaco”, dopo la sconfitta elettorale – è di convincere gli altri che gli vuoi tanto bene, e che hanno il dovere di volerti bene anche loro, però devono farlo alle tue condizioni”. Kane sembra incassare, ma subito propone: “Facciamo un brindisi all’amore alle mie condizioni. Sono le sole condizioni che un uomo rispetta: le proprie”. Non è arroganza: è una solitudine senza spiragli. Per Kane, l’amore è ciò che lo lega alla “gente”; e la gente è pubblico. Della sua seconda moglie dice che è “il campione tipico del pubblico americano”. Il rapporto che tra loro s’instaura, al primo incontro, è quello di un imbonitore con la sua platea: lui muove le orecchie, poi improvvisa sul muro, con le dita, un teatrino di ombre cinesi. Lei si diverte, gli dice: “Ma lei conosce una quantità di giochetti. Non sarà un prestigiatore, per caso?”. E’ una delle scene più struggenti del film. Il piccolo Charlie offre tutto ciò che può dare: una smorfia buffa, un giochetto da bambini. Un titolo cubitale, un matrimonio di sogno, un palazzo favoloso. Cos’altro può pretendere, la gente? Cosa bisogna fare, per essere amati?
*
La parte del film che già dalla prima visione mi ha più straziato, e ancora oggi mi tortura, è quella dedicata alla forzata “carriera” canora di Susan Alexander. C’è una scena, in particolare, che non riesco a togliermi dalla testa: mentre il povero maestro di canto, nella buca del suggeritore, gesticola come un forsennato, Susan, impennacchiata in costume “cartaginese”, pompando fuori l’aria di Salammbô, avanza verso il proscenio. Tra le fettucce del gonnellone punico spuntano le sue gambe, malferme sui tacchi alti da cocktail-party. C’è qualcosa, in quel passo di cicogna, che mi stringe il cuore ancor più della precaria intonazione della signora. A guidarlo è l’opposto di ogni talento, di ogni arte: è la più cieca volontà. Kane – che in cuor suo si sente un uomo di spettacolo ed è un collezionista di cose belle – non ha in realtà la minima idea di che cosa siano l’autentica bellezza, il fascino, la grazia (e il loro contrario). Quando Susan, dopo il tentato suicidio, gli dice “Tu non sai che significhi presentarsi in scena e sentire che il pubblico non ti vuole”, lui non capisce ancora. “E’ sempre così, quando si lotta”, replica. Lo abbiamo visto, dopo l’ennesimo fiasco di lei, restare il solo ad applaudire caparbiamente nel silenzio del suo teatro. Kane “lotta”; ma la sua espressione smarrita mentre ascolta la moglie, dopo aver còlto il commento di uno spettatore (“Agghiacciante!”) ci mostra quanto inconsistenti siano, ai suoi stessi occhi, le cause per cui si batte.
*
Al termine del cinegiornale che apre il film, lo speaker conclude: “E l’altra settimana, come per tutti gli uomini, la morte è venuta anche per Charles Foster Kane”. L’enfasi di maniera non diminuisce la portata della precisazione. Quest’uomo non era immortale. Era come tutti. E come per tutti, anche per lui la morte è il limite, il contorno che dà a un’esistenza la sua forma definitiva. Ma nel caso di Kane – e nel film di Welles – la fine ha un ruolo ulteriore. E’ dalla fine che comincia la storia del “signore di Xanadu”. La morte vi è presente fin dall’inizio; è lei a dare senso agli eventi, a illuminare imprese e fallimenti, affetti e ambizioni. Quella luce suprema, il direttore del cinegiornale vorrebbe afferrarla, pubblicarla: “Non basta dire quello che un uomo ha fatto: bisogna dire quello che era”. Il suo essere, è la fine a dirlo. Dalle ultime parole del morente comincia così un’inchiesta che di nuovo colleziona aneddoti e informazioni, senza sciogliere l’enigma: chi era, che cos’era “Rosabella”? Solo lo spettatore lo saprà, quando vedrà bruciare nel rogo del ciarpame di Xanadu il vecchio slittino del piccolo Charlie, con la scritta “Rosebud”. E – come Kane – non avrà saputo niente.
1. C’è un uomo – un certo uomo –/ che per i poveri, stai pur sicuro,/ fa tutto quel che può!/ Chi sarà mai quest’uomo,/ questo beniamino del destino? […] E’ Charlie Kane! (Trad. mia)
2. A Xanadu Kubla Khan stabilì/ una superba reggia di delizie:/ Alfeo, il sacro fiume, vi scorreva/ in caverne per l’uomo smisurate,/ giù, giù, fino ad un mare senza sole. (Trad. mia)