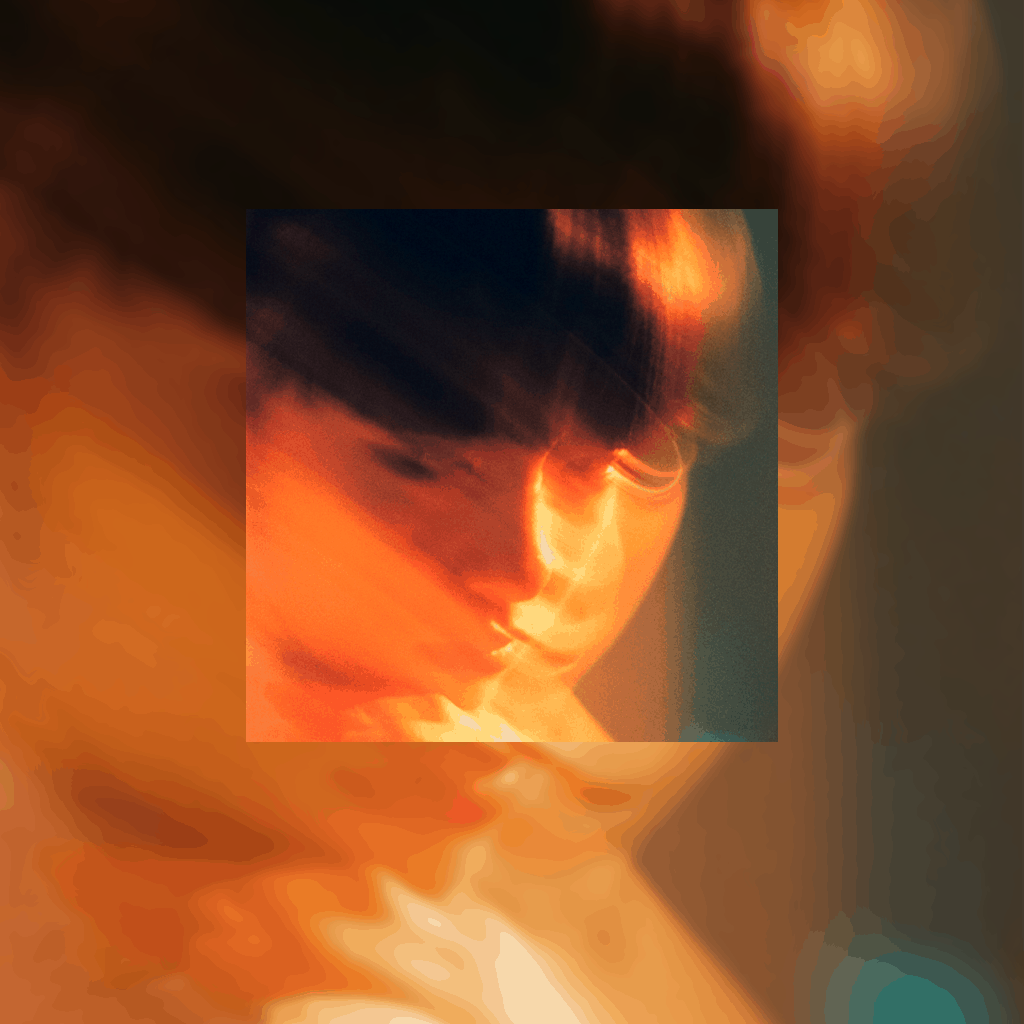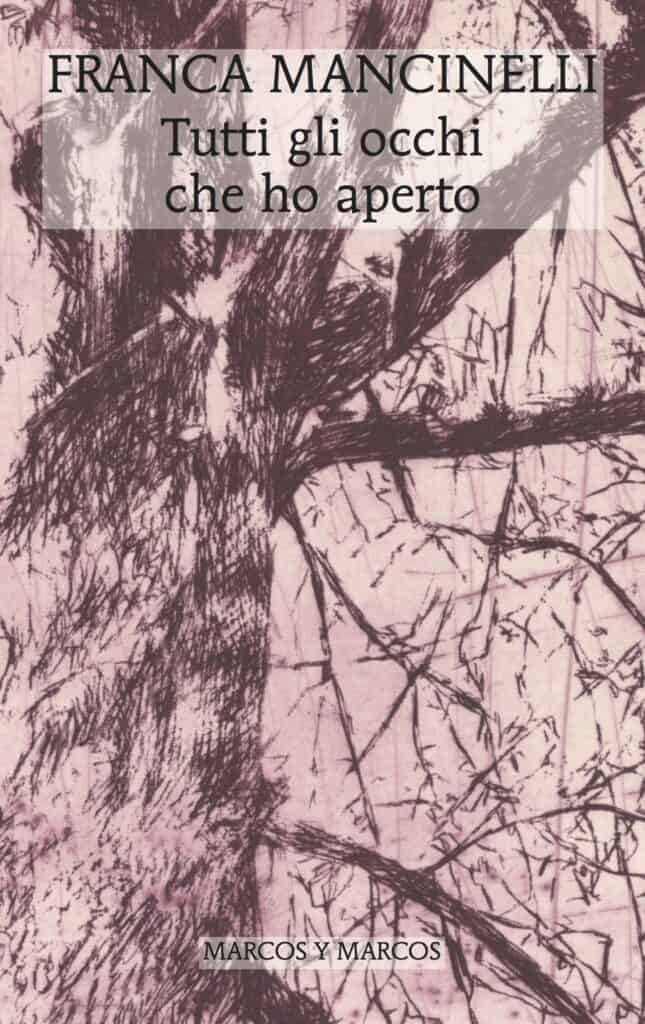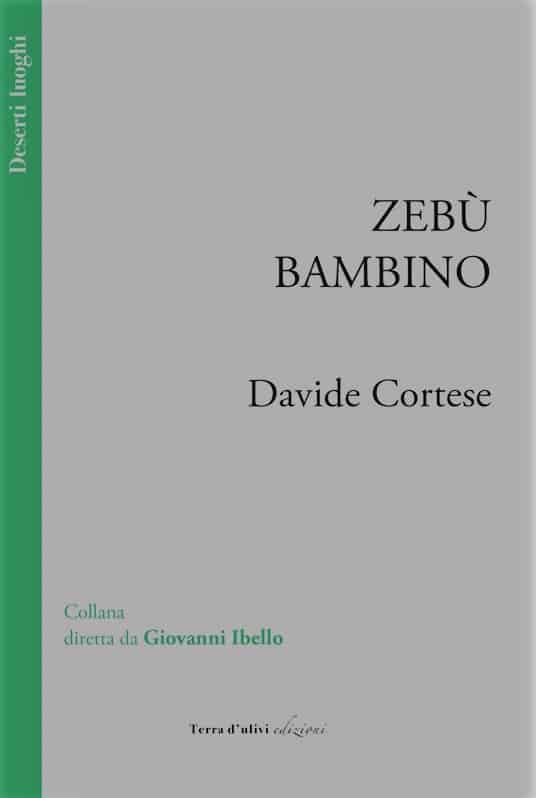Cover: Kosuke Saito da Collater.al
Franca Mancinelli, Marcos Y Marcos, Tutti gli occhi che ho aperto (2020): si potrebbe azzardare come introibo ad un’analisi complessiva del testo in questione il sintagma “libro complicato”: intreccio di viluppi, concrezioni, rizomi e radici in un garbuglio oscuro. La materia, ora arborea, ora umana, che abita le pagine – intervallate da bernoulliane spirali – è declinata secondo una metamorfosi ovidiana, dove ogni occhio che si apre è fiammella d’un altro risveglio. La cornice mattutina è contrassegnata da un senso di rigenerazione ma, altresì, di gettatezza (geworfenheit): ricominciare senza mai giungere a se stessi. La prima sezione, Jungle, è composta da tralicci di prose che, come riporta la nota paratestuale, evocano l’atmosfera d’attesa ulcerata propria della “rotta balcanica”, dove, nella zona liminale di passaggio in Croazia “chi ha bivaccato qui, ora è già forse in Germania. Questione di tempo, di soldi e di fortuna” (p.11). La germinazione di ulteriorità civile, che conduca altrove, è una grana infuocata del libro, pronta a divenire nella sezione Tutti gli occhi che ho aperto storia di metarmorfosi arborea, in cui chi scrive – quindi oltrepassa – ramifica “secondo luce”. Una ridda sapiente d’anastrofi calate in componimenti disposti secondo una myse-en-page nei lembi opposti dello spazio bianco, quale coincidentia oppositorum, raccontano l’agiografia di un albero-uomo, di “bulbi piantati nelle tempie”, di ricerca forsennata di fenditure per ramificare, espandersi e perpetuare il perpetuum carmen: “il muro della casa è senza porta / […] / neanche fatta formica / trovi una fenditura”. La metafisica della luce che sgorga, memoria di Roberto Grossatesta, è la condizione del “tentativo del passaggio”, di qualsiasi frontiera: politica, storica, linguistica, biologica ed ontologica: “crescono i capelli ancora, le unghie / il peso è restituito / all’aria (p.49). Proprio da questa ferita che fatica ad essere feritoia di luce si passa alla sezione Luminiscenze, dove s’annuncia “obbedienza ad una lingua bianca e devastante” (p. 53). In questo caso, con una rugosità stilistica che tende all’ellittico, alla brevitas che si fa anima monca, di nuovo torna in campo la questione del processo di singolarizzazione di ogni occhio aperto dal mondo e nel mondo: “negli occhi chiusi una sorgente / di pupille – luminescenze / trascorse tra globi / custodi di un’unica immagine / gravitante nella polvere esplosa” (p. 65). Tra queste pupille, talune sono però chiamate al destino della chiusura: in questa terra che frana riemerge, come da principio, la topica della condizione dei migranti: in un endecasillabo senza sbavature, si legge: “rinchiusa in bara la barca discende” (p.71). Chiara qua l’ascendenza del componimento – insuperato – Esilii tratto da Historiae di Antonella Anedda: “Oggi penso ai due dei tanti morti affogati / a pochi metri da queste coste soleggiate”. Nella sezione Frammenti per una dedica è dalla feritoia della terra che sgorga il logos: un globo estraneo racconta, sbobinando il lungo negativo della storia come “correnti e stili si succedono (p. 101) dove, però, ancora vivono “intere colline di occhi / spalancati alla luce”. Mancinelli sigilla la sua personale orogenesi, di transiti e luminescenze in questo modo: “la terra, una pagina scura: / ciò che cade si scrive / frantuma e sgrana / nel buio raggiunge / il senso, si perde” (p.107)
Cristiano Poletti, Marcos Y Marcos, Temporali (2019): c’è una commozione tellurica lucreziana che agita, passo dopo passo, questo libro che s’innalza come inno a circoscrivere la dimensione vivida e striata del temporale, contestualmente fenomeno atmosferico, exemplum della paura orginaria, ma anche secca aggettivazione della condizione terrena. Il libro inarca il suo dorso e segna la sua apertura sul lungo canale d’un corridoio: “in casa, una volta entrato, ho trovato / una perdita. Ora / cerco il suo luogo nascosto” (p.4). Stanare la radice ramificata della perdita, la via che conduce più latamente dall’essere al non essere, ergo dalla generazione alla corruzione porta l’itinerarium del poeta sulle orme del De rerum natura di cui è ribollente l’influsso:“ma che parola è l’anima? / passa tutto nel corpo, / sia tuo o mio è già un ricordo” (p.17). La stringente temporalità delle cose della natura è un cappio sempre pronto a nuovi nodi: di lì, anche in questo caso, la diade tra perdita e luce, trasponendo il canto nella spelonca di terzine del Paradiso: Forma dell’ombra, o luce, tu nell’oro / sola t’intendi, e in questa ellissi / temporale che è lotta per la vita /che è sempre e si tramanda / liberaci tu, salvaci (p.14). Si alza la nuca, l’occhio si rivolge alla finestra, a caccia di un bagliore. Eppure, “fuori infuria la storia. / Nella coda degli occhi /una parola tiene (p.14). Se la storia, il suo infuriare, supera la domanda lucreziana sulla natura, è perché al suo decorso corruttivo essa contribuisce a fortiori. L’ipotestualità di Somiglianze, chiaro nel componimento Il perdente “Fuori c’è la storia, / le classi che lottano” (p.62) traccia il sentiero della deflagrazione nella ultima sezione, dove si ripercorre Via Caetani, luogo del ritrovamento di Aldo Moro: “Caetani, Michelangelo / che scrisse del paradiso di Dante / e dell’inferno / che divenne quella via / quella incredibile / tomba rossa Renault / di un nove maggio” (p.73). La perdita di corpi biologici, storici e sociali rincara il sintagma leopardiano “acerbo vero”: “E poi? Ti ricordi? /Tale è lo stato / mortale, il supremo / nostro venir meno” (p.71). L’umanità si tratteggia quale sacca piena d’ore, zavorra d’ere: dalla finestra rimane la paura dei temporali: “Dentro, l’immagine di un ragazzo. /Ed era / stringere negli anni un nervo, fissando / il fuori in fiamme col tremore /dei temporali negli occhi (p.49).
Stelvio Di Spigno, Marcos Y Marcos, Minimo umano (2020): guardare dall’alto il proprio destino, riassumerlo ad occhio nudo, cercare la costellazione che guida la costituzione di un libro. Di qui il sintagma lapidario che funge da titolo: netto tentativo di scovare la quidditas dell’essere umano, quale globulo minimale ne distingue la storia dalle altre specie. Per incanalare nei versi questo interrogativo, nel suo spietato decorso, Di Spigno apre il libro con un componimento encomiastico rivolto ad Alfred Schnittke “tu che facesti la riforma tonale / amante del passato e del suo sangue moribondo / ti scrivo non per lode, né per ringraziare, /solo perché mi hai svelato una via da seguire” (p.9). Le pagine seguono, in una chiara partitura cadenzata da un abile, flessuoso e ritmato uso di inarcature, conducendo, alla ricerca del proprio “minimo”, al franoso tentativo di abbozzare un personale consuntivo dell’esistenza: “e sono in piedi, addirittura, tra tanti / che volevano spuntarla. / E hanno perduto orgoglio e carnagione. / Ora prego per chi mi rimane. /Sono pochi / e senza tutele […] (p.). Tra echi facenti il cenno a Petrarca, gemello nel tentativo di riallineare i fragmenta vitae, la nube di un fantasma (di qui il componimento Ghostling) ha a che fare con la perdurante, anche qui ubiqua, dimensione della perdita: “perduta, mi hai perduto / solo questo destino d’acciaio” (p.20) oppure “sei venuto a vederla da un portico abusivo / la tua vita, oggi perduta, abbandonata” (p.27). Versi che sentono la presenza materna di Amelia Rosselli: “cara vita che mi sei andata perduta”. In una delle sezioni più pregnanti, la questione trova la sua espansione acquatica. In Elegie finali, con esergo tratto dal Filoloco di Boccaccio si legge: “vedi che sto scomparendo / insieme a me la civiltà dell’onore fraterno”. Chi scompare, seguendo i dettami della materia, diventa convitato, ma di pietra di viva come nel caso di Nella: “Anche tu te ne sei andata / oggi compagnia di astralità deformi” (p.33). Tale ulcerato vaticinio di disgregazione si veste poi, in sede conclusiva, come missiva d’aeriforme addio: “lasciatemi andare via, persone un tempo amate […] Non piangete per me. / Dimenticate”. (p.37).